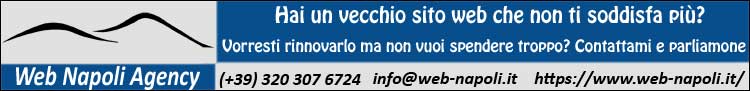Nella vita siamo abituati a correre, sempre. Si corre al mattino, nel tragitto che porta da casa a scuola e poi, qualche anno dopo, da casa al lavoro. Sappiamo tutti che con il fiatone e la mente costantemente applicata a pensare a tutto ciò che bisogna portare a termine durante il giorno, il tempo che resta da dedicare alla riflessione è poco.
Quanti di noi da piccoli sognavano di fare i cantanti, le ballerine, i piloti, gli astronauti. E poi? Poi accade che la scuola, proprio quella che dovrebbe essere una ‘’palestra di vita’,’ in cui avere la possibilità di scoprire e delineare la propria vera indole, ciò per cui si è davvero portati, smette di essere un viaggio alla scoperta di se stessi e assume piuttosto le sembianze di una gara, una corsa concitata. Un percorso in cui il tempo per fermarsi a riflettere sulla propria identità e chi si vuole essere un giorno, non lo si trova davvero. Si viene d’un tratto inghiottiti da quel meccanismo diabolico che è il business, la politica, la società, in cui ogni secondo perso è una ferita, indice di debolezza, segno di qualcuno che non sta facendo le cose ‘’per tempo’’. E in un battito d’ali, il momento in cui bisogna scegliere che carriera intraprendere è già arrivato.
Un problema della generazione attuale
Pressione sociale, viene definita così quella che sta causando fenomeni di depressione nella generazione z. Diversi studi, come quello di Jama Pediatrics del 2024, hanno infatti dimostrato come atteggiamenti di tipo depressivo tra i giovani siano aumentati, in particolare in seguito della pandemia da Covid 19. In Italia, secondo l’OMS, un adolescente su quattro soffre di depressione, quest’ultima viene indicata dall’Istat addirittura come la possibile seconda causa di disabilità al mondo.
Parallelamente all’età, infatti, cresce anche l’incertezza verso il proprio futuro e il timore più che l’eccitazione nell’affrontarlo. Ciò accade, in particolare, da quando lasciamo il liceo e iniziamo l’università. Tutto è fatto di fretta, non si ha il tempo di decidere davvero, di soppesare la propria scelta, di guardarsi dentro con sincerità e porsi domande importanti. Spesso ci si fionda su una facoltà, perché si sa che nel caso contrario si perderebbe una chance, che ci sarebbero altri a prendere il nostro posto, che la società ci ingurgiterebbe facendoci sprofondare in un buco nero senza vie di uscita. Dunque è bene iniziare. Cosa, non è poi così importante. È una corsa, è un si salvi chi può. Spesso la scelta si basa su pochi e semplici criteri: che sia un’università di buona/media fama ma che soprattutto permetta di trovare un lavoro dignitoso una volta terminata. Questi due criteri fanno si che la scelta si ampli o si riduca a seconda della città e della famiglia in cui si ha avuto la fortuna di nascere. E da li, dal giorno zero, il primo di università, inizia quella che si potrebbe chiamare ‘’la più grande corsa della vita’’, tutto ciò che aveva preceduto quel momento equivaleva a un banale allenamento. Obiettivo: fare tutto, bene e soprattutto in fretta, nei tempi giusti.
Solo il 44% degli italiani è soddisfatto del proprio lavoro, riporta l’Associazione Ricerca Felicitá 2024, il resto è insoddisfatto ma comunque non fa nulla per cambiarlo. Secondo la ricerca Changes Unipol-Ipsos tra gli insoddisfatti, il 76% si sta guardando attorno alla ricerca di nuove opportunità ma in realtà solo il 26% sta cercando attivamente. In una società che chiede ai giovani d’oggi gratitudine per le briciole che sta concedendo loro, i giovani rispondono con un si remissivo. Dalle ricerche sopra citate appare l’immagine di una generazione che decide di accontentarsi, come se si smettesse improvvisamente di scavarsi dentro, di conoscersi, di cercare domande e risposte. Potrebbe far pensare al famoso libro di Hannah Arendth, La banalità del male, in cui la scrittrice racconta del processo al criminale nazista Adolf Eichmann nel 1963 a Gerusalemme. L’autrice racconta il processo di un uomo, che tutti si aspettavano essere l’incarnazione del male, eppure ciò che in realtà venne fuori fu l’immagine di una persona che per arrivare a commettere determinate atrocità aveva semplicemente messo a tacere la sua propria coscienza. Era un uomo comune che aveva semplicemente attuato seguendo i principi della cieca obbedienza, incapace di pensare criticamente. Il confronto forse risulta sproporzionato, ma non è forse ciò di cui abbiamo bisogno per renderci conto di quanto sia importante avere una coscienza interiore, quanto sia importante porsi le giuste domande? Come poter accettare di farsi andare bene indistintamente un lavoro, purché sia remunerato, quando occupa praticamente l’80% della giornata di una persona?
E se andare all’estero fosse la soluzione?
Molti decidono di trasferirsi all’estero, magari dopo un percorso universitario eccellente in Italia, sicuri che ciò che il proprio paese può offrirgli non sia abbastanza. Altri partono subito dopo il liceo. Nel 2022 gli espatri hanno superato i rimpatri: quasi 100mila italiani hanno lasciato il Paese, contro 75mila rientri. La maggior parte ha meno di 40 anni e sceglie un altro Stato europeo, soprattutto nell’UE. Lombardia e Veneto guidano l’emigrazione in termini assoluti, ma, in proporzione alla popolazione, spiccano anche Abruzzo e Molise. Il Lazio, invece, registra il tasso più basso. Le grandi città restano i principali punti di partenza: Milano, Roma, Torino e Napoli da sole contano quasi un quinto degli espatri.
Le generazioni passate e il sogno del posto fisso
Sessant’anni fa temi del genere non erano attuali. La generazione dei nostri nonni non si poneva troppe domande. Era quella generazione che sognava il posto fisso, un luogo sicuro, senza eccessivi stress, che permetta di arrivare facilmente a fine mese. Si trattava di una generazione che viveva un momento storico completamente diverso da quello che i giovani d’oggi stanno vivendo. Il boom economico post guerra, internet che non esisteva, i social che non esistevano. Questo implicava anche la mancanza di accesso a quella “finestra sul mondo” che oggi consente a molti adolescenti di esplorare in tempo reale una molteplicità di mondi e di vite, offrendo loro la possibilità di mettere in discussione, ogni giorno, la propria idea di routine. Una finestra capace di suscitare dubbi, rimpianti, perfino gelosie e invidie. Spesso alla base di depressione e isolamento. L’accesso limitato all’informazione, che caratterizzava il passato, corrispondeva anche allora forse a una felicità più a portata di mano? Più facile da conseguire? I social ci danno l’impressione che oggi tutto è possibile, se solo lo si vuole.
Davanti un ventaglio di infinite possibilità, come non essere dunque in crisi?
E ancora le nuove tecnologie, la meccanizzazione e l’automatizzazione di ogni processo, l’aumento dei lavori di ufficio, in cui si è costretti a essere seduti davanti a una scrivania tutto il giorno, ha portato a un appiattimento a un aumento dei lavori statici, in cui I contatti umani sono ridotti al minimo indispensabile. Come pertanto impedire una legittima ricerca di ritrovato calore umano? Fa pur sempre parte della nostra natura no?
Un’indagine globale realizzata dalla società di servizi per la gestione delle risorse umane Kelly Services ci dice che quasi un 1 italiano su 5 è sicuro di aver sbagliato tipo di carriera, assieme a un 23% che invece ammette di non saperlo.
Ma allora come districarsi nel mondo attuale? Il metodo Ikigai potrebbe aiutarci.
Fermarsi. Respirare profondamente e affrontare quel momento da cui in molti tentano di sfuggire. Quello in cui ci si guarda dentro e ci si pone le giuste domande, proprio quelle che tanto fanno paura ma che sono le uniche che forse aiutano a uscire dal labirinto soffocante dei punti interrogativi.
Ikigai è una parola giapponese che indica ”la propria ragione d’essere”.
Possiamo dire che un lavoro può definirci fino a questo punto? Fino a diventare ”la nostra ragione d’essere”? Può raccontare chi siamo al 100%? Si, ma non per forza. Ciò che è sicuro è che siamo solo noi a poterlo scegliere, questo si. Possiamo decidere che quel grande impiego di tempo giornaliero sia qualcosa di più che un modo per portare la pagnotta a casa.
L’ikigai racchiude tutto ciò che amiamo fare, ciò in cui siamo particolarmente abili, che porti allo stesso tempo beneficio al mondo ma anche alla nostra economia personale. Sicuramente si tratta di un’ardua impresa eppure nessuno ci impedisce di provarci. Si potrebbe partire analizzando le proprie passioni, quelle che ci scollegano dalla realtà quando le pratichiamo, quelle azioni che ci fanno azzerare il flusso di pensieri, che accelerano il tempo incredibilmente e che hanno la capacita di stamparci un grosso sorriso in viso e di farci provare una sensazione, senza paragoni, di leggerezza dell’animo. Insomma, quelle che aiutano il rilascio di endorfine e che ci fanno dormire sereni alla sera.
Un altro modo potrebbe essere quello di pensare a come gli altri ci vedono, cosa apprezzano di noi, della nostra personalità. Cosa ci rende unici? Come potremmo impiegare queste qualità in un lavoro? Infine ci si potrebbe domandare come le proprie skills potrebbero adattarsi a un lavoro che porti benefici su chi ci sta attorno e sul mondo in generale. Sperimentare, non mettere a tacere la propria voce interiore, non smettere mai di investigare, di essere curiosi, di fare domande, di ascoltare storie attorno a noi. Provare, riprovare, non arrendersi, cambiare lavoro, avere il coraggio di lasciare una posizione privilegiata dando fiducia alle nostre capacità. Con la convinzione che ognuno meriti un lavoro che invece di svuotarci, al contrario ci riempi e ci faccia sentire in armonia con la terra.