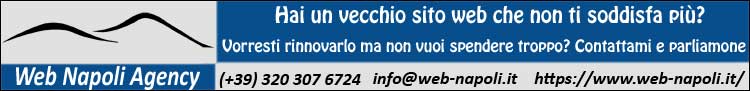Parliamo della nuova normativa sull’obbligo di indicare in etichetta la riduzione del contenuto nei prodotti confezionati, una misura pensata per contrastare la cosiddetta “shrinkflation“. Ma l’UE non l’ha presa bene, e ha lanciato una procedura d’infrazione.
Il cuore della questione è semplice: quando un’azienda riduce il contenuto di un prodotto senza modificare la confezione, il consumatore si ritrova, inconsapevolmente, a pagare di più per meno. Una pratica tanto subdola quanto diffusa. Da qui l’idea — tutto sommato condivisibile — di obbligare i produttori a dichiararlo in etichetta.
Solo che, secondo Bruxelles, questa misura è troppo vincolante, va contro le regole del mercato unico e crea disparità con gli altri Stati membri. Insomma, l’intento sarà pure nobile, ma il metodo — a detta della Commissione — è da rivedere.
Diciamocelo chiaramente: quando si parla di regolamenti europei, si rischia sempre di cadere in un ginepraio di formalismi. In questo caso, la Commissione contesta all’Italia di non aver rispettato il periodo di “standstill” previsto dalla direttiva sulla trasparenza del mercato unico.
Formalismo? Forse! Ma è anche vero che senza regole condivise, ogni Stato rischierebbe di andare per conto proprio, minando l’equilibrio dell’intero sistema.
Al netto delle eccezioni sollevate dall’UE, la norma italiana ha un senso concreto.
È una misura di trasparenza, pensata per tutelare i consumatori da una forma mascherata di inflazione. Non è solo una questione di prezzo: è una questione di fiducia. E oggi, diciamolo, il consumatore ha bisogno più che mai di potersi fidare di ciò che legge su una confezione.
Ti è mai capitato di comprare il solito pacco di biscotti e notare che finisce prima del solito? Ecco, è la shrinkflation. La confezione è identica, ma la grammatura è cambiata.
E il prezzo? Quello resta uguale, se non addirittura più alto. Un vero e proprio gioco di prestigio di marketing, ma con effetti poco trasparenti.
Questo fenomeno non riguarda solo il cibo: coinvolge anche prodotti per la casa e per la cura della persona. Una forma di inflazione silenziosa, che pesa sul carrello senza che ce ne accorgiamo.
Il Codacons, che da anni denuncia la shrinkflation, ha accolto la normativa con una punta di soddisfazione ed una buona dose di rammarico. Soddisfazione perché finalmente il problema è sul tavolo; rammarico perché — come si suol dire — i buoi sono già scappati dalla stalla.
Molti prodotti sono stati già “alleggeriti” da tempo, e obbligare oggi a segnalarlo in etichetta rischia di essere un intervento tardivo. Ma, tutto sommato, meglio tardi che mai!
Ma, se Informare bene è un dovere, come farlo senza creare pasticci? E qui si apre un altro fronte: come informare in modo efficace, senza complicare la vita ai produttori né confondere i consumatori? L’etichetta è uno strumento potente, ma non è l’unico, anzi, sono già state proposte soluzioni alternative, quali la cartellonistica nei punti vendita o le informazioni digitali accessibili tramite QR Code. La sfida è trovare un equilibrio tra efficacia comunicativa e sostenibilità operativa.
Oggi il packaging è molto più che un contenitore: è un mezzo di comunicazione, un’espressione del brand, un elemento di storytelling. L’etichetta è un “touchpoint”, un punto di contatto che può valorizzare o penalizzare l’identità del prodotto. In questo senso, obblighi come quello italiano possono essere percepiti come limiti, ma potrebbero diventare un’occasione per distinguersi raccontando la propria trasparenza.
Molte aziende, soprattutto le PMI, vedono nelle normative un ostacolo alla competitività, ma forse è il momento di ripensare alla comunicazione di prodotto. Trasformare un obbligo in una leva di branding — con strumenti digitali, packaging più narrativi o contenuti interattivi — potrebbe diventare un vantaggio competitivo.
E qualche esempio virtuoso già c’è: piccoli produttori che hanno fatto della trasparenza il loro punto di forza, guadagnando fiducia e fidelizzazione.
Siamo davanti a un nodo complesso – che non si può sciogliere rapidamente con un colpo dei spada – come fu il caso del famoso nodo gordiano.
Da un lato, la tutela dei consumatori. Dall’altro, la libertà di mercato. In mezzo, un’Europa che cerca di armonizzare ma che alla fin fine rischia di omologare. Forse, la soluzione non è solo normativa, ma culturale.
Perché alla fine, che sia scritto su un’etichetta o raccontato in una campagna, ciò che conta davvero è il rispetto per chi compra ed anche per chi, con fatica e onestà, produce.