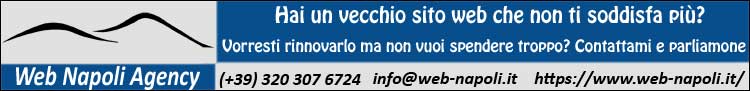Questa è la storia del sale, certo. Ma anche, e forse soprattutto, la storia di noi, di come ci siamo organizzati, ribellati, evoluti, e perfino civilizzati attorno ad un cristallo bianco. Che, guarda caso, insaporisce tutto tranne la sua stessa importanza.
Siamo nel Neolitico, il periodo in cui l’umanità smette di inseguire le prede e comincia a coltivare la terra. Ed è lì che il sale entra nella nostra dieta e nella nostra storia, diventando una risorsa indispensabile. Perché mi chiederete? Beh, perché la carne ed il pesce, che allora non si conservavano certo sottovuoto, potevano essere trattati proprio con il sale per poterli conservare. E chi aveva sale, aveva potere.
È curioso – ma non troppo – che già nel Neolitico esistessero rotte commerciali per lo scambio del sale. Alcune recenti scoperte archeologiche parlano chiaro: vasellame contenente cristalli di sale, resti di saline, tracciati commerciali. Una proto-economia basata su ciò che oggi troviamo a pochi centesimi.
Dai sumeri agli egizi fino ai romani, il sale assume un ruolo polifunzionale: alimento, conservante, medicina, simbolo. In Mesopotamia era usato per conservare la carne, mentre in Egitto diventava strumento essenziale nella mummificazione. E con Roma il discorso si allarga: qui il sale entra nel sistema, diventa pilastro della società civile.
Plinio il Vecchio, nella sua “Naturalis Historia”, gli dedica ben sette capitoli. Non si limita a elencarne i benefici gastronomici. Parla di disinfezione, digestione, medicina preventiva. Il sale, per i romani, era parte integrante della cultura materiale e spirituale.
Non è un caso se il termine salario deriva proprio dal sale. I soldati dell’Impero spesso ricevevano una parte del loro compenso sotto forma di sale, o meglio, con denaro destinato a comprarlo. Era un bene prezioso, al pari di oro e grano.
La Via Salaria, come suggerisce il nome, era una strada militare e commerciale costruita per trasportare il sale dalle saline di Ostia verso l’entroterra. Un’infrastruttura strategica ante litteram.
Religiosamente, il sale assumeva un valore sacrale. La mola salsa, usata nei riti di purificazione, era una miscela di farina e sale. E ancora oggi, nell’acqua benedetta cristiana, sopravvive la traccia di quella tradizione.
Con il Medioevo, il sale diventa strategia. La Repubblica di Venezia costruisce parte della sua potenza economica sul monopolio del sale: dalle saline di Chioggia e Comacchio fino alle rotte adriatiche e orientali. Cipro, Creta, Corfù: ogni nodo commerciale è presidiato. Ogni sacco di sale è una moneta, una leva diplomatica.
Pisa non resta a guardare e, controllando il commercio toscano, impone tariffe sempre più alte. Firenze, si racconta, reagisce con un gesto tanto simbolico quanto destinato a fare scuola: il pane sciapo. Tradizione che ancora oggi caratterizza la cucina toscana. E anche se forse la leggenda è un po’ “ricamata”, è innegabile che il sale in quei secoli non fosse solo condimento ma arma politica.
1648: a Mosca scoppia una rivolta per l’aumento della tassa sul sale imposto dallo zar Alessio I. I palazzi dei nobili vengono assaltati, gli esattori inseguiti per strada. Un’insurrezione vera e propria. E in Spagna, nel 1631, a seguito di una tassa simile voluta da Filippo IV, la Catalogna esplode in proteste.
Ma il caso più emblematico resta quello francese. La gabelle, introdotta nel 1300, obbligava ogni suddito ad acquistare una quota fissa di sale, anche se non ne aveva bisogno. Era l’emblema dell’iniquità fiscale dell’Ancien Régime. Non a caso, tra le prime richieste dei Cahiers de Doléances nel 1789, c’è proprio l’abolizione della tassa sul sale. E infatti, nel 1790, scompare. Il sale aveva vinto.
Anche in Italia il sale è stato terreno di scontro. Nel 1540, la cosiddetta “guerra del sale” tra Perugia e lo Stato Pontificio termina con un bagno di sangue e il declino economico della città. Firenze e Pisa si fronteggiano a colpi di pane insipido e dazi doganali.
Con l’Unità d’Italia, la fiscalità diventa ancora più aggressiva: per unificare i bilanci degli stati preunitari, si decide di tassare ciò che è essenziale. Risultato? Il sale diventa un lusso per i ceti popolari. Esattamente l’opposto di quanto serviva.
Nel frattempo, dall’altra parte del mondo, Gandhi guida la Marcia del Sale del 1930, simbolo della disobbedienza civile contro l’impero britannico. Un gesto semplice – raccogliere una manciata di sale – che scosse un impero.
Chi l’avrebbe detto che anche il gelato ha avuto i suoi problemi col sale? I sorbettieri dell’Ottocento usavano miscele eutettiche – cioè composte di ghiaccio e sale – per ottenere le temperature necessarie. Ma proprio quel sale veniva tassato. E quindi, per i gelatai, ogni coppetta diventava una questione fiscale.
Il legislatore, evidentemente, non distingueva tra sale da cucina e sale tecnico. E così, il gelato divenne un “bene di lusso” tassato come se fosse caviale.
Angelo Celli e Francesco Saverio Nitti, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, denunciano con forza il carattere regressivo del monopolio del sale. Le classi popolari, con diete a base vegetale, avevano un bisogno fisiologico maggiore di sale. Ma proprio loro ne pagavano il prezzo più alto.
E i numeri lo confermano: per decenni, l’Italia ha avuto consumi pro capite di sale inferiori di oltre il 30% rispetto a Francia, Germania e Regno Unito. Una dieta già povera veniva ulteriormente penalizzata. Il sale, insomma, diventava misura di disuguaglianza.
Bisogna aspettare il 1974 per l’abolizione definitiva del monopolio sul sale in Italia. Ma già da qualche decennio qualcosa stava cambiando: l’avvento del frigorifero domestico e il miglioramento delle catene del freddo stavano rivoluzionando la conservazione degli alimenti.
Il sale tornava a essere ciò che era: un esaltatore di sapidità, non più una necessità imposta dalle condizioni tecniche. E con lui si riscoprivano produzioni di qualità: prosciutti, formaggi stagionati, acciughe. Non più un obbligo, ma una scelta gastronomica.
E oggi? Oggi il sale è tornato protagonista, ma in modo completamente diverso. Il sale marino di Trapani è IGP e presidio Slow Food. Quello di Cervia segue lo stesso percorso, anche senza certificazioni ufficiali. È il sale che si “raccoglie a mano”, che “non viene lavato”, che “mantiene la sua umidità naturale”.
Certo, stiamo pur sempre parlando di cloruro di sodio. Ma nella contemporaneità gastronomica, il significato supera spesso la sostanza. E allora via libera al “sale biologico”, al “sale rosa dell’Himalaya”, al packaging sostenibile. Perché, alla fine, anche il sale ha imparato a vendersi bene.
Il sale non è solo sapore. È storia, economia, simbolismo, lotta. Ha alimentato imperi, fatto crollare regimi, nutrito proteste e identità. E in fondo, anche oggi, non potremmo farne a meno.
Aggiungiamo sale per dare gusto. Ma anche per ricordare. Perché, come diceva Bunuel: “Il sesso senza peccato è come un uovo senza sale”. E forse, anche la storia senza sale… non avrebbe mai avuto questo sapore.