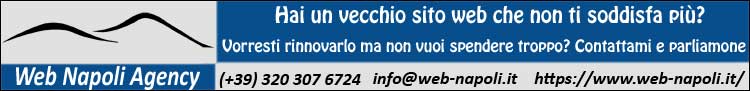Ecco perché parlare oggi di mare libero non è solo una questione politica. È un’esigenza culturale, ecologica, esistenziale. Una chiamata a rimettere ordine nelle nostre priorità ed a rimettere il mare – bene comune per definizione – al centro dello spazio pubblico, fisico e simbolico.
La terza conferenza nazionale dei Comitati di Mare Libero, tenutasi a Napoli presso l’ex Asilo Filangieri, ha segnato un punto di svolta. Da battaglia diffusa ma spesso isolata, quella per la liberazione delle spiagge si è fatta strategia condivisa, rete, orizzonte internazionale. Malta, Grecia e Spagna, tre paesi che, pur con dinamiche differenti, affrontano la stessa deriva neoliberista del litorale, quella che trasforma le coste in proprietà privata mascherata da concessione.
Il salto di scala è fondamentale. E non solo perché l’Unione Europea impone una disciplina comune in materia di concorrenza e accesso ai beni pubblici. Ma perché serve una visione transnazionale per affrontare processi che sono sistemici: turistificazione, speculazione, denitrificazione. Non si tratta più solo di difendere il bagnasciuga sotto casa. Si tratta di restituire senso, valore e accessibilità ad uno spazio che appartiene a tutti.
Il cosiddetto “modello balneare italiano” è, a voler essere generosi, un paradosso normativo. Un sistema fondato sulla proroga perpetua delle concessioni demaniali marittime, spesso affidate senza gara ed a condizioni economiche irrisorie, che ha cristallizzato un regime di fatto privatistico su beni che, giuridicamente, dovrebbero essere inalienabili.
A rendere la questione ancora più spinosa è il fatto che questo sistema – difeso a spada tratta da lobby potenti e da amministrazioni locali compiacenti – è palesemente in contrasto con la Direttiva Bolkestein, oltre che con i principi costituzionali di uguaglianza e libera fruizione dei beni comuni.
Le spiagge italiane, secondo dati diffusi da Legambiente, sono occupate per oltre il 60% da stabilimenti balneari. In alcune regioni, come Liguria ed Emilia-Romagna, la percentuale supera l’80%. E la tendenza è in aumento. Ogni proroga, anche quella per la stagione 2024-2025, è una violazione reiterata. E non è una questione ideologica: è una questione di diritto.
Un tempo le città costiere vivevano rivolte verso il mare. Oggi molte di esse gli voltano le spalle. Intere porzioni di litorale sono inaccessibili, separate da recinzioni, parcheggi privati, barriere architettoniche e sociali. Le spiagge, da spazio pubblico, sono diventate una sorta di club esclusivo.
La proposta di Mare Libero è chiara e radicale: riaprire le spiagge alla collettività, restituire accessi, garantire continuità fisica e simbolica tra città e mare. Non si tratta solo di lasciare qualche metro libero tra uno stabilimento e l’altro, ma di ripensare all’uso stesso del demanio costiero. Serve una nuova pianificazione urbana e territoriale, capace di considerare le spiagge come parte integrante del tessuto civico.
Il mare, in questo scenario, diventa spazio di relazione, educazione ambientale, inclusione sociale. E le spiagge non sono più “servizi turistici”, ma ambienti pubblici da tutelare e vivere.
Napoli, con la sua storia stratificata ed il suo rapporto passionale con il mare, non poteva che essere il luogo ideale per rilanciare la battaglia. L’ex Asilo Filangieri, spazio liberato e autogestito, ha ospitato un evento che è andato ben oltre il convegno classico. C’erano avvocati, urbanisti, attivisti ambientali ed altre associazioni nazionali quali Italia Nostra, Legambiente, WWF. Ma c’erano anche artisti, performer, narratori. Perché la lotta, quando è autentica, chiama a raccolta tutti i linguaggi.
Il confronto è stato serrato, ma aperto. Dalle esperienze di micro-resistenza alle proposte legislative, dalle azioni simboliche alle strategie di comunicazione. È emersa una consapevolezza forte: per difendere il mare serve una narrazione nuova, che parli alla testa e al cuore.
Che sappia costruire senso comune, oltre il tecnicismo giuridico.
Riva Fiorita, angolo nascosto di Posillipo, è diventata il simbolo di una battaglia più ampia. Qui, dove un tempo si accedeva liberamente, oggi ci sono cancelli, divieti e sorveglianza privata. Ma la legge parla chiaro: le servitù di passaggio al mare devono essere garantite. E allora l’azione messa in campo da Mare Libero – stendere simbolicamente gli asciugamani su quella spiaggia interdetta – è diventata un atto di riappropriazione collettiva.
Un gesto pacifico ma determinato, capace di ribaltare il senso comune: non siamo noi a dover giustificare la presenza in spiaggia, sono i privati a dover giustificare l’esclusione.
Il claim “Tutte le spiagge sono libere” non è una provocazione. È una rivendicazione fondata su dati, norme e princìpi. Il demanio marittimo è, per definizione, un bene inalienabile e imprescrittibile. Le concessioni sono, o dovrebbero essere, temporanee e finalizzate all’erogazione di servizi, non all’occupazione esclusiva dello spazio.
Eppure, in nome di una distorta idea di turismo, abbiamo accettato che il diritto all’accesso fosse subordinato al pagamento di un ombrellone e di un lettino. Un paradosso che ci allontana dal modello europeo e ci inchioda a una logica da anni ’80, fatta di rendite, clientele e abusi.
La verità è che chi stende l’asciugamano su una spiaggia libera non sta “invadendo” nulla, anzi sta esercitando un diritto. E chi tenta di allontanarlo – con arroganza o con minacce – è fuori legge.
Uno degli aspetti più interessanti del movimento Mare Libero è la sua capacità di andare oltre la dimensione giuridica. Certo, ci sono ricorsi, istanze, appelli. Ma c’è anche una forte componente culturale, narrativa, artistica. Perché la difesa dei beni comuni passa anche attraverso l’immaginario.
Le spiagge liberate diventano luoghi di incontro, performance, dibattiti, laboratori per bambini. Si sperimenta una nuova idea di spazio pubblico, più inclusiva, più creativa, più viva. E in questo, Mare Libero rappresenta un esempio virtuoso di “advocacy popolare”: un mix tra azione diretta e comunicazione efficace, tra rigore e poesia.
Se sei arrivato a leggere fin qui, probabilmente anche tu senti che qualcosa non torna. Che l’idea di dover pagare per accedere al mare è, in fondo, un’anomalia. Che lo spazio pubblico non può essere recintato. E allora non serve molto: basta esserci. Basta portarsi l’ombrellone da casa. Basta non farsi intimidire. Basta sapere che la legge, questa volta, è dalla nostra parte.
Questa estate – come tutte le estati – ci sarà chi proverà a dirti che lì non puoi stare. Che quella è “zona riservata”. Tu rispondi con calma, con rispetto, ma con fermezza: è una spiaggia libera.
E se ti guardano storto, spiega loro che difendere il mare non è solo un diritto, ma è un dovere. Perché un giorno – forse non lontano – quel mare sarà tutto ciò che ci resta.