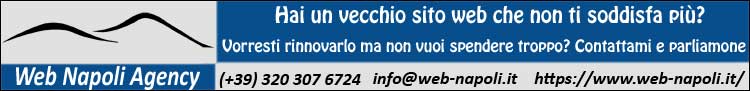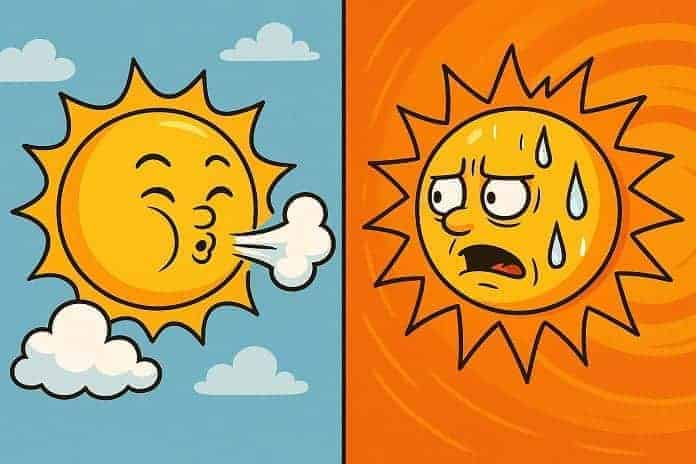Ora, sarà una mia deformazione professionale, ma ogni volta che sento quel “record” mi viene da alzare il sopracciglio. Record rispetto a cosa, esattamente? Alla media trentennale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale? Ai dati dell’Aeronautica Militare? O magari alla memoria personale del giornalista di turno?
Perché un record, per definizione, presuppone un confronto. Se si ignora il riferimento temporale e geografico, se manca la base dati, quello che resta è solo una parola vuota, piazzata lì per generare attenzione. Una scorciatoia retorica che, però, ha un prezzo: banalizzare la comunicazione, impoverirla, renderla un esercizio di enfasi anziché di informazione.
Il termometro emotivo delle previsioni meteo. Una delle trovate più affascinanti – e per certi versi più subdole – degli ultimi anni è la temperatura “percepita”. Non basta più sapere quanti gradi ci sono. No, adesso ci devono anche dire come li sentiamo.
La percezione termica, in sé, è un concetto tecnico assolutamente legittimo: tiene conto di temperatura reale, umidità relativa, irraggiamento solare e della ventilazione. Esiste un indice specifico – l’Humidex in Canada, o l’Heat Index negli Stati Uniti – che sintetizza tutto questo.
Ma come spesso accade, quando un concetto scientifico viene sdoganato nei media generalisti – si da quelli come noi, ma noi cerchiamo di non fare così – finisce per essere semplificato, stiracchiato, gonfiato. Ed ecco che i “32 gradi reali” diventano facilmente “40 percepiti”, senza spiegazioni, senza contesto, senza nemmeno il beneficio del dubbio.
La conseguenza? Un’informazione che più che orientare, disorienta. Che più che avvisare, allarma. E che spesso, purtroppo, finisce per essere strumentalizzata: per fare audience, per spingere contenuti, per alimentare quel filone narrativo – ormai ben rodato – della catastrofe quotidiana.
C’è una curiosa analogia tra il ciclo delle stagioni e quello delle notizie. Entrambi seguono un ritmo ricorrente, un battito prevedibile ma mai del tutto identico. Il punto, però, è che mentre la natura si ripete in modo armonico, la narrazione mediatica tende a farlo in modo ossessivo, quasi compulsivo.
Le previsioni meteo ne sono un esempio perfetto. Non importa che sia luglio o dicembre, ci sarà sempre un titolo d’effetto: “Italia nella morsa del gelo!”, oppure “L’anticiclone africano infiamma le città!”. E se non bastasse, ci penseranno le mappe colorate – rigorosamente in rosso fuoco – a completare l’opera.
Tutto questo, ovviamente, fa parte di un meccanismo ben preciso: il ciclo vitale della notizia. Che dura, in media, sette giorni. Sette giorni in cui un argomento viene sviscerato, amplificato, esasperato. Finché non arriva qualcosa di più fresco – o più caldo, a seconda della stagione – a spodestarlo. Il principio è semplice: l’informazione segue le logiche dell’intrattenimento. E quando l’interesse scema, si cambia scena.
Mi viene in mente un caso emblematico. Alcuni anni fa, un grave incidente ferroviario aprì tutti i notiziari. Una notizia certamente drammatica. Ma nei giorni successivi, pur di mantenere alta la tensione, i media iniziarono a scovare disservizi ovunque. Anche lì dove c’era poco o nulla.
E così, ricordo bene, si arrivò a titolare: “Pendolari intrappolati in un vagone a Milano Centrale”. L’immagine era quella dei passeggeri dietro ai vetri delle porte a soffietto. In attesa, sì, ma più per noia che per panico. Nessun ferito, nessun guasto strutturale. Solo un malfunzionamento temporaneo.
Era un incidente ferroviario, quello? O solo una forzatura narrativa? A giudicare dal servizio, sembrava la scena madre di un film catastrofico. A ben guardare, era solo l’ennesima occasione per montare un caso. A margine, naturalmente, le previsioni meteo.
Il messaggio implicito? Che ogni piccolo disagio è notizia. Che ogni normale episodio di cronaca può essere nobilitato – o drammatizzato – in nome dell’attenzione. È un’operazione sottile, ma efficace. E, nel lungo periodo, corrosiva.
In fondo, questa strategia mediatica si appoggia a una componente profondamente umana: la lamentela. Siamo un popolo incline a mugugnare, a enfatizzare i disagi, a cercare il colpevole anche quando non c’è.
E i media lo sanno bene. Anzi, ci hanno costruito sopra interi format. Dai talk show serali ai contenitori del pomeriggio, passando per i reality dell’indignazione permanente, il messaggio è sempre lo stesso: c’è qualcosa che non va, e dobbiamo protestare. Sempre!
Il caldo, il freddo, le buche, i treni, la sanità, la scuola. Ogni elemento del quotidiano può diventare il pretesto per un racconto conflittuale. Il risultato? Un sistema informativo che non spiega, non contesta, non verifica: semplicemente amplifica ciò che fa rumore.
E così, anche un’oscillazione normale delle temperature diventa l’occasione per scomodare l’epica. Per dire che siamo al limite. Che non si era mai visto nulla di simile. Che è “record”. Ancora una volta, e basta!.
Previsioni? Certo, le facciamo anche noi. Con spirito, ironia e poca presunzione e a volte anche poco “azzeccate”. Prima di tutto, una doverosa premessa: il nostro è un servizio meteo settimanale, quindi con quel tocco di approssimazione che lo rende inevitabilmente impreciso, ma straordinariamente umano. E lo diciamo con orgoglio. Sì, perché il nostro obiettivo non è certo quello di gareggiare con chi trasforma ogni variazione di temperatura nell’ultimo dramma nazionale, ma piuttosto raccontare il tempo – e l’esposizione del clima – con ironia, leggerezza e, quando serve, un pizzico di spirito critico.
Ci piace pensare che, più che previsioni, offriamo visioni. E che il nostro meteo settimanale sia un antidoto alle previsioni apocalittiche da telegiornale, quelle che ogni tre per due gridano al “caldo africano” o alla “morsa polare”, come se l’estate e l’inverno non fossero mai esistiti prima. Qui si ride (anche di noi stessi), si riflette e si cerca di capire come le parole – anche quelle meteorologiche – possano essere usate per informare, ma anche per manipolare.
Arriviamo al punto. Con questo non voglio sminuire il tema del cambiamento climatico. Assolutamente no. Né sottovalutare l’importanza della comunicazione meteorologica. Tutt’altro. Ma proprio per questo, credo che sia fondamentale usare le parole con precisione. E, quando serve, anche con sobrietà.
Dire che ogni estate è “la più calda di sempre” senza specificare il periodo di riferimento, la fonte dei dati, o il contesto climatico, non è solo scorretto. È controproducente. Perché genera assuefazione, scetticismo, cinismo. E finisce col minare la credibilità della stessa informazione scientifica.
La comunicazione, specie quella pubblica, ha un compito delicato: aiutare a comprendere, non solo a reagire. Non servono titoli shock. Serve consapevolezza. Serve metodo. Serve responsabilità.
E soprattutto, serve ricordarsi che non tutto fa notizia. A volte, semplicemente, fa caldo perché è estate o freddo perché è inverno. E questo, per quanto possa sembrare banale, è ancora perfettamente normale.