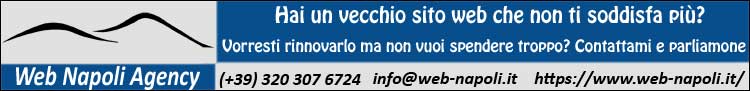Nato nel 1933 a Napoli, in via Pignasecca, nel cuore brulicante di umanità del centro storico, De Simone si è formato come concertista al Conservatorio San Pietro a Majella. Ma quella era solo la superficie, ben presto sceglie di deviare dalla strada canonica della carriera accademica per addentrarsi in un territorio molto più complesso: la memoria popolare. Non il folklore da cartolina, ma la tradizione viva, stratificata, attraversata da contraddizioni e simboli profondi.
Nel 1967 fonda, insieme ad altri studiosi e artisti, la Nuova Compagnia di Canto Popolare un laboratorio di ricerca e restauro del patrimonio orale campano. Canti contadini, nenie liturgiche, voci di festa e di dolore, tutto viene raccolto, trascritto, studiato, ma non si ferma lì. De Simone rielabora quel materiale con taglio colto, drammaturgico, spingendosi verso un teatro musicale nuovo, ibrido, capace di parlare tanto alla pancia quanto alla testa.
Con la sua opera più famosa, “La Gatta Cenerentola”, debutta nel 1976 al Festival dei Due Mondi di Spoleto, ed è un’opera che rappresenta uno spartiacque. È un intreccio audace di fiaba barocca, canto popolare e riflessione politica. Un’opera che porta in scena la Napoli arcaica e la trasforma in mito moderno. Ma ridurre De Simone a quella sola pietra miliare sarebbe ingeneroso: il suo repertorio spazia da “La Cantata dei Pastori” a “Requiem per Pasolini”, da “Mistero Napoletano” al recente “Concerto per Maradona”. Ogni opera è uno scontro culturale, dove l’immaginario collettivo viene riletto con rigore filologico e tensione poetica.
Il Maestro De Simone era un compositore, un pensatore, un pedagogista, un costruttore di senso. Da direttore del Conservatorio San Pietro a Majella (1995-2000), rilancia la centralità dell’istituzione attraverso la valorizzazione della Biblioteca storica ed una visione formativa che va oltre la mera tecnica musicale. Per lui, l’educazione era un atto politico, non era il come si suona, ma perché si suona, non era da dove viene il suono e dove può condurci.
Napoli è sempre stata il personaggio principale per ogni sua opera. Non la Napoli oleografica, da cartolina, ma quella profondamente contraddittoria, affascinante e disturbante, sacra e profana. Quella che sa farsi corpo, gesto, canto. Roberto De Simone ha avuto il coraggio di portare in scena questa città senza filtri, raccontandone la ferocia e la grazia, le ombre e la luce. Il suo teatro era un rito laico, una liturgia collettiva che mescolava passato e presente, popolo e intellettuali, artisti e devoti.
Il rapporto con il teatro Trianon Viviani di Forcella è stato emblematico. Nel 2002 inaugura la riapertura del teatro con la riscrittura di “Eden Teatro” di Raffaele Viviani. Nel 2021, con la regia di Davide Iodice e la direzione musicale del nipote Alessandro, firma “Trianon Opera”, che tra pupi, sceneggiate e bel canto è una sorta di testamento artistico, la summa visionaria di tutta la sua poetica. Lo spettacolo, trasmesso su Rai5 e ancora disponibile su RaiPlay, ed è un’opera-simbolo, dove ogni riferimento diventa citazione colta, ed ogni gesto in scena un atto di fedeltà alla cultura partenopea.
Tra le sue frasi più celebri, una su tutte spicca per lucidità: “La figura del Diavolo rappresenta la morte dell’immaginario. La cultura contemporanea, tutta protesa verso la tecnologia, sta uccidendo il sogno.” Parole che oggi suonano come un monito, perché il sogno, per Roberto De Simone, non era evasione, ma fondamento di ogni vero atto creativo. L’immaginazione era il vero strumento di resistenza e, se oggi la cultura sembra sempre più addomesticata, il suo teatro ci ricorda che può ancora essere provocazione, mistero, turbamento.
Non stupisce che il cordoglio per la sua morte sia arrivato da ogni angolo del mondo culturale: dal Ministro della Cultura al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dal Conservatorio al Teatro San Carlo, dall’Università Federico II al teatro Trianon Viviani. Ognuno ne ha ricordato l’opera e l’eredità.
Mercoledì 9 aprile alle ore 16, nella Cattedrale di Napoli, si terranno i funerali del Maestro officiati dal cardinale Battaglia. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. La camera ardente sarà allestita nel Foyer del Teatro San Carlo, con apertura al pubblico martedì 8 aprile dalle 13 alle 19. Alle 13:30, in un momento che si preannuncia di forte impatto emotivo, il quartetto d’archi del Teatro eseguirà il Requiem di Mozart in suo onore. Anche mercoledì 9 sarà possibile rendere omaggio a De Simone, dalle 10 alle 14.
Oggi più che mai, la sua assenza si misura nel vuoto che lascia e nella quantità di domande che riapre: che cos’è la tradizione? Come si trasmette la memoria? Che posto ha il mito nella contemporaneità? De Simone ci ha lasciato le coordinate per affrontare queste domande. Tocca a noi non smarrirle.
E si, Napoli perde un frammento profondo della propria anima, ma in cambio riceve un’eredità viva, fatta di spartiti, parole, visioni, gesti. Un patrimonio che non si conserva in teche, ma si tramanda nel teatro, nei quartieri, nelle scuole, nelle mani di chi avrà la forza ed il coraggio di ascoltare davvero. E forse — anzi, sicuramente — è proprio questo, il modo migliore per continuare ad onorarlo.